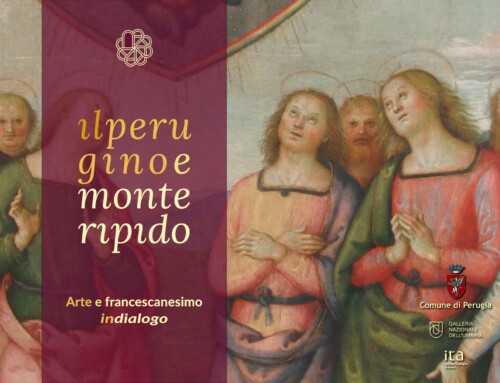Si è svolto a Roma, dal 21 al 23 giugno, il convegno dell’ACRU (Associazione Collegi e Residenze Universitarie), rivolto a direttori ed educatori impegni nel servizio di accoglienza di giovani in molteplici in strutture ubicate in molteplici città universitarie. È stata un’esperienza di amicizia, anzitutto, segnata da un clima piacevole, accogliente e semplice. Questo almeno è stato per me. Momenti di riflessione, di preghiera, di convivialità e di arte hanno segnato il nostro percorso, dal titolo: “Compagni di viaggio, testimoni di un Incontro. Prendersi a cuore la vita di tutti”.
Questo primo appuntamento di formazione che ACRU rivolge a direttori e ad educatori è stato centrato sulla figura dell’educatore e sull’intensionalità educativa.
L’avvio dei lavori ha avuto luogo con il saluto di Mons. Giuliodori, assistente spirituali dell’Università Cattolica, che con paterna sollecitudine segue e sostiene le iniziative di ACRU. Papa Francesco – ha detto Mons. Giuliodori – sollecita la pastorale giovanile a divenire sempre più abile ad incontrare i giovani laddove essi vivono, in un tempo in cui i ragazzi e le ragazze con facilità perdono il contatto con la Chiesa. Le Università cattoliche sono chiamate a essere luogo di intercettazione dei giovani. I nostri collegi sono luoghi dove ci mettiamo in cammino insieme ai nostri giorni, per ascoltare le istanze che si portano dentro ed accompagnarli a scoprire la vocazione a cui il Signore li chiama. Il servizio delle residenze universitarie è un tassello importante della pastorale universitaria.
Ha fatto seguito l’intervento di don Armando Matteo, di cui proponiamo una sintesi.
Professore di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, con una ricca esperienza di studente presso uno dei collegi dell’Università Cattolica, don Armando ha proposto una riflessione, acuta e stimolante, sul profilo dell’educatore a partire da uno sguardo sui nostri tempi, a partire da una citazione di Gustavo Zagrebelskj, il quale, in Senza adulti, si chiede: “dove sono gli uomini e le donne adulte?”. La mancanza di adulti è una costatazione, afferma don Armando. Assistiamo a un processo di “degiovanimento” e allo spostamento del compimento dell’umano, non più identificato con l’età adulta, intesa come quel tempo della vita in cui si è capaci di dimenticarsi di sé per far felici gli altri.
L’adulto è colui che investe i propri talenti per far crescere l’altro, come attestato dalla Scrittura – «c’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) – ma anche dalla nostra esperienza concreta. L’adulto è colui che è passato dalla domanda “chi sono io?” alla domanda “Per chi vivo io?”.
Dopo la Seconda Guerra mondiale si è diffusa l’idea secondo cui la forma compiuta dell’essere umano non è nella fase adulta della vita, ma nella giovinezza. Papa Francesco in Christus vivit, al n. 182, parla di «adorazione della giovinezza».
I 31 milioni di adulti italiani hanno smesso di essere riferimento per i giovani. Oggi l’adulto è felice di essere al mondo nella misura in cui è in grado di offrire le sue performance. Il senso dell’umano trova espressione nel farmaco più conosciuto oggi al mondo, il viagra, il farmaco che promette la possibilità di essere sempre all’altezza.
Il processo che ha condotto a questo cambiamento culturale ha avuto inizio nel secondo dopoguerra, in cui si sono verificate delle trasformazioni incredibili, in pochissimi decenni:
- longevità. Dopo la seconda guerra mondiale le generazioni hanno conquistato trenta anni di vita (la prospettiva di vita per un uomo era intorno ai 55 anni). Nel 1989, quando nasce l’ente da cui è nato l’odierno Inps, avevano previsto di dare le pensioni dal compimento dei 65 anni di età. La pensione era pertanto concepita per le vedove, dato che le donne erano più longeve. La morte prematura degli uomini, inoltre, era motivo di stabilità dei matrimoni. La nostra specie non era preparata ad avere così tanti anziani e così tanti in salute. Un settantenne di oggi è paragonabile a un cinquantenne degli anni 80.
- aumento del benessere. Siamo le generazioni più ricche della storia. Da un punto di vista simbolico è significativo: ciò che distingue un adulto da un giovane è solo un reddito maggiore.
- maggiore disponibilità di tempo per sé stessi. La lavatrice ha donato 90 minuti di tempo al giorno alle donne, che per la prima volta dispongono di tempo per sé. Dal 1957 in Italia viene resa obbligatoria la frequenza della scuola fino alle medie. C’è un nuovo vigore nell’universo femminile. Nel 1960 viene inventata la pillola, che permette alle donne una riconciliazione con il sesso.
Tutto questo è esaltante, e va anche salutato con una certa empatia, ma produce una radicale trasformazione dell’essere adulti. Alcuni esempi? In Italia si spendono 30 milioni l’anno per evitare la caduta dei capelli, anche se è ben noto che nessuna tecnica si è dimostrata risolutiva. Siamo il paese più medicalizzato del mondo, ma abbiamo anche i bambini più obesi di Europa. Il motivo è dato dal fatto che i genitori non riescono a vedere l’aumento del peso del figlio. Questo è cambiato: il modo di vedere il piccolo, ritenuto capace di scegliere autonomamente, a partire dalle scelte alimentari, che di certo sono più dettate dal gusto che dalla correttezza. È cambiato il modo di concepire la vecchiaia: un’indagine rileva che si ci ritiene anziani a 83 anni, mentre l’aspettativa media di vita è di 82, 6 anni (!). In ultimo, grazie alla maggiore longevità e al benessere che sperimentiamo in questo mondo, è venuto meno il senso della morte: a Roma, ad esempio, non si usa più affiggere i manifesti funebri.
Cambiando il modo di concepire la vita, cambia anche il modo di pensare l’educazione. Nel momento in cui l’adulto non si legge più in chiave vocazionale, l’educazione va riscritta: avendo assolutizzato la giovinezza come il senso della vita, cambia il modo in cui i genitori interpretano l’essere del figlio e come il figlio percepisce, di conseguenza, la propria identità.
I nati tra il ‘46 e l’80 hanno un rapporto straordinario con questa vita. Siamo la risposta all’invito di Nietszche: “Fratelli, siate fedeli a questa terra!”. È successo che tutto il senso positivo della vecchiaia l’abbiamo trasportato sui bambini, che diventa l’esperienza dell’umano compiuto. Bambino viene da babbeo, infante, minore,… il bambino è l’essere precocemente competente. Non è più l’essere che ha bisogno di tante sollecitazioni, sostegno, e anche di qualcuno che gli faccia da specchio. È un umano più piccolo, ma un umano completo.
Al bambino vengono riconosciute la capacità di intendere, che il Catechismo della Chiesa Cattolica riconosce invece dai 7 anni. In Svizzera c’è un’azienda che chiede 26 mila euro per fare un’indagine per scoprire il nome giusto del bambino (cf. Genitori elicottero), perché si ritiene che un bambino nasca già completo, per cui il nome deve rispecchiare l’essere già compiuto che il neonato è.
Questo cambiamento rende inutile l’educazione. L’unica educazione necessaria si ritiene debba preservare ciò che il piccolo è. Anche le dinamiche intra-familiari vengono rese superflue, come del resto anche quelle extra-familiari, come la scuola, in cui il ruolo delle maestre è spesso squalificato. La partecipazione al mondo scolastico, sportivo e parrocchiale diventa l’occasione per esibire il “piccolo messia”. Tutte le istituzioni si trovano in una paralisi pazzesca.
Questo produce un’immagine sfasata del soggetto giovane. Oggi siamo nell’epoca nel narcisismo. Non deve sorprenderci, se già prima di venire al mondo i figli sono trattati da divinità. Tutto questo si trasforma in una vulnerabilità, un azzeramento della capacità del soggetto, e dall’altra ad una permalosità che arriva al patologico. Dietro tutto questo c’è un’origine perversa (cf. autori del calibro di Andreoli, Recalcati, Risé, …).
Le doti straordinarie riconosciute nel figlio diventano per i genitori una giustificazione per dedicarsi ad altro. Questo è il limite più grande e delicato dell’attuale modo di essere genitori. Questo fenomeno comporta un processo di handicappazione dei figli, che è riflesso del desiderio di immortalità degli adulti. Per non invecchiare, gli altri devono aver bisogno di me. Come si fa ad essere educatore in questo contesto?
È necessario recuperare i tratti fondamentali di un educatore:
1) è ponte tra il mondo e i figli. Far uscire il giovane dal mondo che si è creato, inevitabilmente, per fare da ponte verso il mondo così come è. Rispetto al mondo ciascuno di noi è una “capra”. Non c’è nulla di più salvifico che riconoscere che difronte alla complessità della vita siamo “capre”, come direbbe Sgarbi. Ricordiamo l’insegnamento di Tagore: “i tuoi figli non sono figli tuoi”, sono del mondo, per il mondo.
2) è un allenatore. L’educatore deve esser capace di vivere la conflittualità, che nasce ogni volta che si mette in atto in processo educativo. Questo si muove verso una duplice direzione: voler bene e volere il bene. Per voler il bene dell’altro a volte bisogna andare contro l’altro e questo atteggiamento tante volte può essere frainteso come mancanza di affetto verso l’educato. Diversamente da come pensano tanti, il quarto comandamento non è “ama mamma e papà”, ma “onora il padre e la madre”, cioè “riconosci il peso dei tuoi genitori”. L’educatore non ambisce ad essere amato, ma a ricevere anzitutto il rispetto, da parte degli educandi, il loro onore, per evocare il linguaggio biblico del quarto comandamento.
3) è un poeta. Aiuta il giovane a porsi la domanda: “ma è vero che il tutto di noi è qui?”. L’educatore aiuta a comprendere che non siamo solo quello che di noi mostriamo. C’è in noi uno spazio che nei documenti di Concilio Vaticano II è chiamato “sacrario”. Educare significa aiutare a vedere ciò che non si vede, mediante l’arte, la preghiera, il volontariato, la politica, …i giovani ci sono perché al mondo ancora manca qualcosa, che solo loro possono dare. Più aiutiamo i giovani a prendere consapevolezza di ciò che manca dentro di loro, più li prepariamo a dare al mondo quello che ancora gli manca.
Il progetto educativo. Intervento del prof. Pierpaolo Triani – Università Cattolica di Milano
L’educazione è un’azione strutturata, intenzionale ed è un’azione – dal punto di vista dell’antropologia cristiana – che intende promuovere la formazione della persona, che è un percorso personale.
La vita collegiale è in sé formativa (o de-formativa). Poi bisogna vedere se è educativa o no. Se la vita dei collegi è in sé formativa, ha senso impegnarsi a progettare delle azioni intenzionali. Se siamo qui è perché crediamo abbia senso incontrare con le nostre azioni educative il processo formativo dei ragazzi. Parlare di progetto educativo vuol dire avere voglia di scommettere sulla forza dei significati, capaci di aprire la vita a un processo di crescita, di fecondità. Vuol dire volere scommettere sul dono che la comunità vuole condividere con i ragazzi, vuole scoprire e mettere in circolo. Parlare di progetti educativi vuol dire credere che i giovani hanno necessità anche di qualcosa d’altro rispetto al soddisfacimento dei bisogni. Il progetto educativo è un atto di fiducia molto forte verso i giovani. Parlare di progetto educativo vuol dire scommette sulla capacità dei giovani di prendere il largo. Significa anche scommettere sulla loro capacità di uscire da sé stessi, per mettersi in gioco con gli altri e con le proposte che ricevono. Questa è una scommessa che deve e vuole fare i conti con l’oggi, con le caratteristiche della cultura di oggi. È una scommessa consapevole, vuole tradursi in una dinamica di un’esperienza buona. Avere un progetto educativo non è fabbricare l’uomo, il progetto non è essere previsionali. Avere un progetto è invece avere la visione di un’esperienza dinamica, buona, da far vivere.
Passaggi che verranno messi in luce, anzitutto le sfide:
- la vita universitaria sta cambiando, e quindi sta cambiando il profilo degli studenti. L’università di oggi si è accorciata (con le triennali) e, insieme, allungata (le lauree magistrali si sono allungate), ma è meno lineare rispetto al passato. L’esperienza buona dentro il modificarsi del tempo diventa una sfida ancora più ardua nella mobilità della vita universitaria. L’università si è specializzata ma anche frammentata. Non abbiamo un unico tipo di studenti e studentesse. Non ci sono più gli stessi tempi che scandiscono in contemporanea la vita dei vari dipartimenti.
- i giovani universitari oggi si formano e crescono in una cultura, in una koiné, che ha delle implicanze educative ben precise:
- i giovani vivono nel tempo del pluralismo delle visioni di vita, delle possibilità almeno ideali. È un tempo di grande potenzialità, perché possono davvero incontrare l’altro, decentrandosi, ma è anche il tempo del rischio del relativismo (di fronte a tante visioni non c’è nessuna per cui impegnarsi fino in fondo, se non in sé stessi)
- primato del benessere dell’io a discapito del bene della comunità. Anche questo ha dei vantaggi molto positivi, dopo secoli in cui l’io venivano schiacciato in comunità chiuse su sé stesse. Viviamo un tempo di investimento sull’io con il rischio di narcisismo, ma dall’altra parte di poter investire in dialogo che pone attenzione alla persona.
- Un altro aspetto legato al tempo della soggettività è il tentativo di eliminare non solo le sofferenze ma anche la fatica.
- La connessione internet. Il tempo della connessione, che implica contatti molto veloci e facili, permette una potente condivisione delle idee. Il rischio è però quello di confondere la comunicazione con l’espressività.
I giovani universitari sono anagraficamente adulti. Noi lavoriamo con degli adulti e vanno trattati come tali, ma dentro un processo di strutturazione che va ancora consolidandosi, per questo li chiamiamo giovani. Sono in processo di rafforzamento della loro maturità ma sono adulti. Il collegio si trova in una posizione delicata, perché rischia, da un lato, di bloccare il processo di autonomizzazione e, dell’altro può favorire un processo di precoce autonomia.
La sfida educativa è sempre la stessa: aiutare ogni persona a fare unità, a fare una sintesi, ad essere capace di rispondere autonomamente alla domanda di fondo: per chi e per che cosa voglio vivere?
Le sfide non si vincono né si perdono, ma possono essere affrontate attraverso l’intenzione di costruire ambienti umanizzanti, capace di coltivare la persona e far in modo che la persona possa diventare sempre più autentica. Non si intende fabbricare persone, ma lavorare quotidianamente per creare condizioni che favoriscano una esperienza buona per i giovani. Qui sta la funzione del progetto educativo.
Se è educativo, il progetto non può essere lineare, meramente previsionale. Il progetto educativo non può essere pensato come una sequenza di azioni, ma come una mappa di orientamento che ci guida nel nostro cammino ordinario, che ci permette di avere dei criteri con cui leggere la situazione. La mappa dell’esperienza umana è sempre in movimento – attenzione! la mappa che abbiano in testa mai corrisponde alle persone e al loro percorso – ma ci permettere di leggere la persona. C’è sempre una distanza tra le carte e la vita. Sempre. Un progetto ci può servire per dare orientamento alle nostre azioni, per pensarle, giudicarle, rinnovarle. Un progetto educativo non può essere pensato in termini applicati, perché cambia facendolo. Con il progetto possiamo imparare facendo, al fine di riflettere sull’esperienza fatta. Si impara facendo nella misura in cui si legge criticamente l’esperienza. Il progetto educativo è una mappa non solo per far funzionare un’organizzazione: per questo può bastare un regolamento. È una mappa per costruire esperienze di vita, che le stesse persone che lo vivono contribuiscono a far crescere. Ogni progetto è diverso, perché disegna a modo proprio quelli che sono i fattori basilari di una proposta comunitaria.
Quali sono i fattori basiliari di una proposta comunitaria?
- I suoi significati portanti. Quali significati vogliamo che i giovani respirino attraverso l’esperienza comunitaria?
- Le relazioni. Come e quanto e quando le persone riescono ad incontrarsi? Quali sono le forme relazionali che promuoviamo?
- I gesti. Una proposta comunitaria è fatta di gesti. Quali gesti caratterizzano il nostro stare insieme? Ci sono dei riti che viviamo in modo particolare? Una comunità è caratterizzata anche dai suoi linguaggi, tanto che ogni comunità si costruisce il gergo proprio. La comunità è plasmata dal linguaggio e dalle cose che si usano e si scambiano. Quali sono le parole e le cose della nostra vita comunitaria?
- Una comunità è plasmata dalla qualità dei suoi spazi e dai suoi tempi.
- Forme partecipative. Una comunità è plasmata dai dispositivi di partecipazione.
Tutti questi fattori sono disegnati in maniera diversa, a seconda delle finalità che ci proponiamo. Una caserma ha una finalità diversa rispetto alla vita comunitaria che si prefigge un collegio. Cambino finalità, processi educativi, metodo e figure educative che intendiamo mettere in gioco.
- Finalità. La finalità più immediata, ma anche quella più sostanziale, è permettere un’esperienza bella e buona, che non vuol dire tranquilla e rassicurante. È chiaro che l’esperienza immediata è tesa ad un’altra finalità più grande: contribuire ad una formazione umana integrale. Contribuire vuol dire non presumere di poterla esaurire. Intendiamo promuovere un umanesimo integrale, multidimensionale. Il rischio di separare il corpo dagli affetti è molto forte. Intendiamo promuovere un umanesimo relazionale: crediamo che promuovere una qualità dell’io significhi impegnarsi nelle relazioni in cui l’io si apre al tu. Un umanesimo comunitario e fraterno. Questo significa promuovere una visione dell’uomo in cui la vita in comune è un elemento imprescindibile, ma per nulla bucolico: stare con l’altro richiede tanta fatica. Umanesimo cosciente della fragilità. I ragazzi che incontriamo mostrano che la fragilità ci appartiene. Umanesimo aperto al futuro con speranza. Un umanesimo trascendente, aperto al mistero di Dio, che si pone a confronto con le parole radicali del Vangelo. L’umanesimo che noi viviamo è invece poco attento alla dimensione trascendente. A volte ci accontentiamo che il ragazzo sia buono, mentre l’esperienza del collegio ha la possibilità di fare molto di più: gettare dei semi che potranno un giorno fiorire nella vita del giovane. Non ci possiamo accontentare che i giovani siano bravi. Dobbiamo puntare alla loro fecondità.
- Le persone si formano nella misura in cui cerchiamo di attivare dei processi formativi, dinamici. Attraverso questa esperienza vogliamo aiutare i giovani a farli crescere:
- nella cura di sé, anzitutto,
- nello studio e nella vita ordinaria, imparando a disciplinarsi
- nell’attenzione all’altro
- nel protagonismo
- nella capacità di rispondere alle domande che la vita pone
- nel dono di sé
- nel porre attenzione alle proprie domande interiori
- nell’apertura alla trascendenza
Il progetto serve per dare un quadro unitario a queste intenzioni. Per attuare il progetto non basta scriverlo, non basta dire che è importante. Occorre agire, dare metodo, senza credere però che sia il tutto. La vita di un collegio che voglia essere educativo dovrebbe operare in modo tale che i giovani possano:
- incontrare esistenzialmente dei valori. Noi respiriamo dei significati, anzitutto nella loro forma incarnata (Cf. Bernard Loner)
- far fare esperienza di questi significati, anche chiedendo che le azioni che siano coerenti.
- occorre operare in modo che i giovani possano riflettere sui significati che si è provato a stimolare in loro
- aiutarli a costruire unità di tutta l’esperienza di vita universitaria. Se il collegio contribuisce a una ultieriore frammentazione allora il processo formativo è fallito.
Le figure di riferimento sono indispensabili. Il fine ultimo dell’educatore è essere effettivo punto di riferimento per i giovani e il loro cammino.
Compiti degli educatori sono:
- la vitalizzazione, cioè rendere vivo l’ambiente.
- costruire e custodire le condizioni per un’esperienza buona. Qui c’è l’aspetto della regolamentazione. Regolamentare è necessario per costruire le condizioni affinché si realizzi l’esperienza buona. Co-costruire le condizioni e custodirle.
- Non è un caso che questo sia un termine molto usato da papa Francesco. Si può pensare che oggi venga privilegiato il termine “accompagnare” perché non osiamo impiegare il termine “guidare”. Sarebbe un errore leggere in contrapposizione i due verbi: l’accompagnare è un processo di crescita con le persone. Va considerato che l’altro ha la possibilità di dire no, non ci sto. È significativo che meno diventa vero l’accompagnamento simbolico da parte dei genitori più diventa invadente il loro accompagnamento fisico.
Lo stile educativo che proponiamo ruota attorno a 4 parole:
- Ascolto
- Attenzione
- Non stiamo zitti, ma facciamo fare delle cose
- Supporto
Lo stile delle figure di riferimento dovrebbe essere di condivisione e di collaborazione. L’educazione non è un’impresa solitaria! L’accompagnamento richiede non un’unica figura ma un’equipe educativa. I giovani non sono i destinatari dell’azione educativa, ma i collaboratori. Nel collegio tutti siamo responsabili dell’esperienza degli altri: i giovani stessi sono educatori! Non sono i destinatari di un’azione educativa ma gli attori.